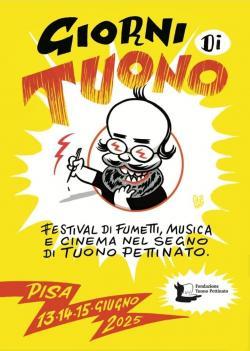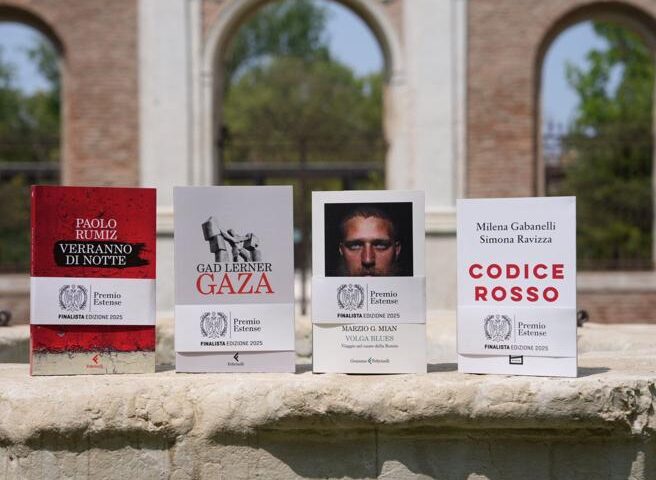Ribellatevi! La rivoluzione del XXI secolo (Meltemi, pp. 370, euro 20 – in libreria dal 16 maggio, ndr) non è soltanto il manifesto di un leader politico o il pamphlet di un intellettuale engagé, ma, per usare le parole dell’autore, una «teoria per l’azione». Il volume di Jean-Luc Mélenchon propone una strategia rivoluzionaria ispirata alla lunga tradizione marxista e all’altezza delle sfide del XXI secolo: non come mito nostalgico né come utopia astratta, bensì come urgenza concreta, frutto del lavoro d’inchiesta e discussione dell’Institut La Boétie (ILB), la fondazione culturale di La France Insoumise (LFI).
Quattro momenti chiave della storia francese recente hanno segnato questa ricerca: l’occupazione della Place de la République nota come Nuit Debout e la mobilitazione sindacale contro la Loi Travail, nel 2016; la sollevazione dei Gilet Gialli, iniziata nel 2018; lo sciopero contro la riforma delle pensioni di Macron, esploso a novembre 2019; e l’insurrezione antirazzista seguita all’omicidio poliziesco del giovane Nahel a giugno 2023. A questi si aggiunge il movimento della «Palestina globale», che ha attraversato la società francese ben oltre i confini della militanza tradizionale a sostegno del popolo palestinese. Si tratta di rivolte diverse ed eterogenee, ma che condividono una comune radicalità basata sulla tensione verso la giustizia, la riappropriazione dello spazio e la liberazione del tempo. Il volume di Mélenchon mette in evidenza i principali aspetti di questo e altri straordinari cicli di lotte e li interpreta come prefigurazioni della rivoluzione del XXI secolo.
PER PENSARE il nuovo processo rivoluzionario, affronta quattro assi di riflessione, che costituiscono le istanze centrali del «programma di rottura» sostenuto da LFI e, almeno per un periodo, dal Nouveau Front Populaire (NFP) – la coalizione della sinistra guidata da LFI, capace di contendere a liberali e fascisti l’accesso al secondo turno delle elezioni parlamentari nel 2024. Mélenchon parte dall’analisi dello spazio-tempo del «capitalismo di rete». A suo avviso, il capitalismo non è più soltanto un sistema economico fondato sulla produzione e lo sfruttamento, ma diventa una macchina predatoria della cooperazione sociale, dei flussi digitali e delle infrastrutture vitali. Ciò che Marx nei Grundrisse definiva General Intellect prende qui il nome di Noosfera: la sfera materiale, cognitiva e relazionale che emerge dalle connessioni tra soggetti, saperi, corpi e tecnologie. È contro questo spazio-tempo capitalistico che bisogna lottare riprendendo una delle intuizioni dei Gilet Gialli: bloccare i flussi e occupare le rotonde in quanto snodi della logistica.
La lotta dentro lo spazio-tempo del capitale la portano avanti i «molti», che si trasformano in «popolo» quando insorgono contro l’oligarchia. L’autore attribuisce un ruolo strategico al «gran numero» (grand nombre) degli esseri umani. L’«era del popolo» (ère du peuple) è per lui il «tempo dei molti». La «rivoluzione cittadina» non va allora confusa con la «rivoluzione civica», la «rivoluzione civile», o la «rivoluzione dei cittadini», espressioni che evocano immaginari molto distanti dalla sinistra di rottura di cui questo libro si fa eco teorica.
Nel discorso di Mélenchon, non si tratta peraltro di riprendere l’idea di un «popolo» prodotto dall’alto e rappresentato dal leader, secondo le teorie di Mouffe e Laclau. I «molti» che fanno la rivoluzione delineano infatti il profilo di una classe lavoratrice rinnovata e attraversata da desideri di liberazione all’intersezione tra sfruttamento economico, dominio coloniale, oppressione patriarcale e distruzione della natura.
DALL’ANALISI del «tempo dei molti» nasce la proposta della pianificazione ecologica, decentrata e multiscalare. Prendendo le distanze dall’uso neoliberale dei modelli cibernetici, la pianificazione proposta da Mélenchon armonizza la pluralità dei tempi umani e non umani: compone la regola verde con la giustizia sociale. Un’altra intuizione dei Gilet Gialli – il rifiuto della «tassa carbone» espresso all’insegna di un’ecologia popolare – è così ripresa da Mélenchon. Per comprendere la dimensione democratica della «pianificazione ecologica» è interessante leggere la versione del 2025 del programma di LFI. Vi si trovano i principi del «municipalismo» e del «comunalismo»: temi su cui in Italia sono stati fatti degli esperimenti esemplari. In questo senso, la proposta della «pianificazione ecologica» non sfugge ma, anzi, valorizza le tensioni e le contraddizioni della sinistra rivoluzionaria francese. Per un verso, richiama il mito della Rivoluzione come momento fondativo della République «una e indivisibile»; per un altro, riattiva l’immaginario della Comune di Parigi come laboratorio metropolitano e cosmopolita, che rimette in discussione la forma-Stato.
IN QUESTO CONTESTO emerge il concetto di creolizzazione, che chiude il volume. Nel discorso di Mélenchon, «creolizzazione» non è sinonimo di multiculturalismo, perché non si limita alla tolleranza di culture diverse, rimanda piuttosto alla costruzione attiva di un universalismo concreto, frutto di incontri e ibridazioni impreviste. La fonte è il poeta e filosofo anticoloniale Édouard Glissant, per il quale non si tratta di integrare chi è stato escluso, ma di ridefinire le basi materiali del vivere insieme e trasformare il modo di intendere identità e cittadinanza. Nella misura in cui scardina i codici razziali, epistemici e linguistici della modernità coloniale, la «creolizzazione» suscita orrore non solo nei reazionari, ma anche in quei settori della sinistra che promuovono un modello astratto di «universalismo», restio ad accettare la decolonizzazione. Per Mélenchon, al contrario, la «nuova Francia» non può essere pensata nei termini dell’assimilazionismo monoculturale della tradizione repubblicana, ma deve emergere dalla pluralità di storie che costituiscono la realtà del paese: dalle banlieues e dai migranti, dalle lotte femministe e da quelle ecologiste.
PER IL LETTORE ITALIANO, questo libro offre uno spunto di riflessione e un incoraggiamento. In un paese come l’Italia, dove non esiste una forza politica capace di tenere insieme coerenza strategica, radicalità programmatica e progetto contro-egemonico, questa esperienza non vale come modello da importare, ma come stimolo per aprire una breccia. Quello di LFI è certo un modello caratterizzato da forti ambiguità. Prima fra tutte, il suo funzionamento gerarchico, centrato sulla figura del leader: un limite strutturale per un progetto che si propone di superare la «monarchia presidenziale» della V Repubblica francese e che intende incarnare l’istanza democratica delle rivoluzioni contemporanee. Eppure, anche nel contesto italiano, l’intuizione di Mélenchon sull’abbandono della strategia socialdemocratica si rivela attuale.
L’esperienza di LFI mostra infatti che, oggi più che mai, la sinistra è di rottura o semplicemente non è. Di fronte alla guerra e alla crisi climatica, a una rinnovata violenza coloniale e alla riaffermazione identitaria dei valori occidentali, è urgente rilanciare un progetto di sinistra pacifista e decoloniale, ecologista e moltitudinaria. Anche in Italia, la rivoluzione dei molti è possibile. Ma non verrà da sé: va pensata, organizzata, sperimentata. Questo libro costituisce un contributo a tale impresa.
* Venerdì 16 al Lingotto (ore 12, Pad. 3 Sala Azzurra), l’autore sarà in conversazione con Andrea Fabozzi.